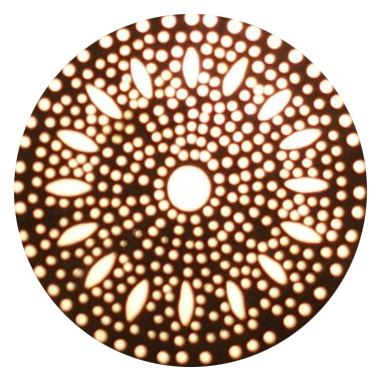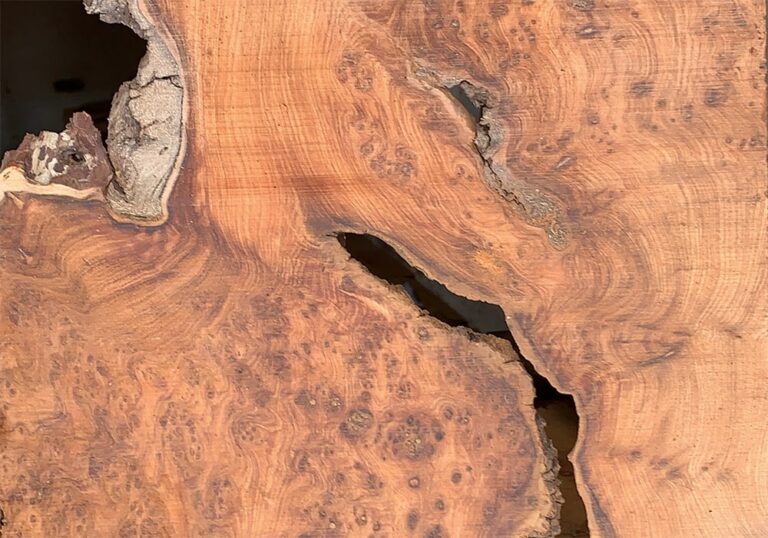Tangeri e il Gran cafè de Paris
Prendendo Tangeri come un posto da approfondire, come del resto potrebbe essere preso qualunque altro posto sul pianeta, e prendendo per buona la teoria secondo la quale alcuni posti coincidono con determinati stati d’animo, si nota subito come, per via dell’aria che si respira e dei cornicioni tutti sbeccati, la città si adatti particolarmente bene ad esprimere sentimenti d’angoscia.
D’altro canto c’è anche da dire che in alcuni punti soprattutto del quartiere spagnolo, per qualche strana ragione dovuta ai colori sbiaditi delle facciate, al passare del tempo, e al degrado, le case sembra che colino. E il posto più angosciato di Tangeri, e quindi anche inevitabilmente più carico di seduzione, è il Gran Cafè de Paris, che è il caffè storico, intellettuale, dove andava Paul Bowles, e dove tutto è leggermente consumato e sembra sempre che ci siano le mosche, e che faccia più caldo che fuori in strada, tanto che i divani, per esempio, in pelle scura, hanno ancora le impronte dei sederi che hanno ospitato a migliaia, prima del mio, sederi di scrittori americani che venivano qui a parlare con Bowles. Così appollaiato sul divano con la pelle scura e la faccia magra, e gli occhi neri e leggermente consumati e i capelli scurissimi, come del resto avevano anche quasi tutti gli altri marocchini presenti nel locale, per un momento mi mancò l’aria e il respiro, mi sembrò di morire, e di confondermi troppo col posto in cui mi trovavo, tanto che finii per maledirlo. D’altro canto maledire l’Africa è un passo inevitabile per un viaggiatore come me, e anche molto letterario se vogliamo. Voglio dire che, in alcune circostanze dovute quasi sempre al disagio e alla stanchezza, maledire l’Africa è consentito. E così per un attimo sprofondato nelle poltrone per il caldo, e la fatica ebbi la sensazione di non riuscire nemmeno più ad alzarmi, come disse Ungaretti. In quella poesia sul fiume, quando parla delle sue quattro ossa da tirare su. A onor del vero però c’erauna ragazza mora alla mia destra che mi distrasse, spostata leggermente indietro rispetto a me, di buona famiglia senz’altro, e marocchina, sprofondata anche lei nella poltrona, col marito, che guardava il cellulare mentre lui pagava, e sembrava morire sul divano intanto che non c’era nessuno, tanto che mi presi il rischio di fotografarla e osservarla confondersi col resto del locale, come se tutta l’Africa la cui luce era entrata inesorabilmente lì dentro impermeando in particolare me e lei fosse un commiato da qualcosa. Tutto è stanco laggiù. E sa’ di morte. E Tangeri, più che a uno stato d’animo, corrisponde simbolicamente al gesto di levarsi le mosche dalla faccia. E pensare che Bowles era amico di uno che ho conosciuto, un anziano signore, distinto e molto ricco, che è anche l’organizzatore del più importante Festival del jazz di tutta l’Africa, nonché presidente di un centro culturale di tutto rispetto che si trova cinquecento metri più avanti, rispetto al Gran Caffè, prima dell’ingresso nella Medina, ovvero prima che la Medina ti risucchi.
Il te’ nel deserto scritto da Paul Bowles nel 1949 e trasformato in film da Bertolucci nel 1990 parla esattamente di questo, cioè di quel sentimento di stanchezza che è nascosto nelle cose e in particolare a Tangeri, e che fa puzzare ogni cosa di morte, compresi i viaggiatori stanchi e intellettuali come me, oltre alla corruttibilità delle cose, e alla sua bellezza. In particolare il film parla di un musicista interpretato da John Malkovich che cerca in giro per l’Africa, nelle cose decadenti che si sfrangono nelle mani appena le tocchi, la bellezza. E così si mette in viaggio per noia, con la propria compagna, lui musicista, lei niente, ma molto bella, interpretata da Debra Winger, per un viaggio senza meta, come viaggiatori non turisti che si lasciano trasportare da se stessi, ricchissimi, ai quali il denaro non interessa. E infatti John Malkovich muore annoiato lanciando banconote, a caso, e ridendo, non tanto in segno di disprezzo verso il denaro quanto in segno di disprezzo verso la morte, come se tutta la vita fosse stata una barzelletta che aveva capito solo in quel momento. Un attimo prima di morire.
E morendo, dice ai musicisti marocchini che lo circondano coi tamburi, e che suonano ma senza capire niente, di continuare a suonare, disperato, Suonate! dice, ridendo, e battendo le mani e trasmettendo un nichilismo che solo Bertolucci sa esprimere così. Un senso di nausea, molto simile a quando Marlon Brando prima di buttarsi dal balcone si leva il chewingum e lo attacca alla ringhiera in Ultimo Tango a Parigi. E me lo immagino Paul Bowles, nella sua casa di Tangeri, con quel caldo, magari scacciando le mosche, a scrivere quella scena che poi sarà interpretata da John Malkovich, il cui personaggio inventò ispirandosi a se stesso, che ride, prima di morire. E non si pente.